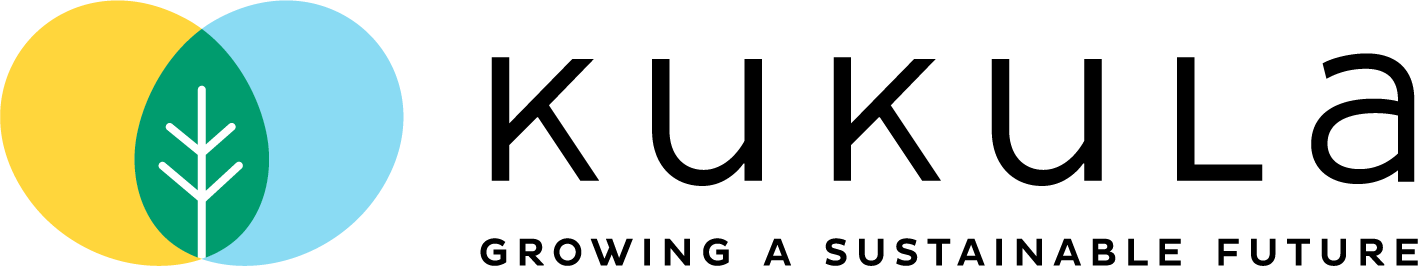L’ape è un animale straordinario.
Sporgersi ad ammirare il percorso evolutivo che ha portato all’affermazione di un insetto sociale così complesso e in un certo senso “perfetto” ci coinvolge in un viaggio meraviglioso attraverso il regno vegetale e animale, e ci porta a interrogativi molto profondi sugli equilibri dell’ecosistema.
In effetti, prima che l’ape fosse un’ape, il mondo era essenzialmente monocolore (era ovviamente verde, ma all’occhio dell’ape doveva apparire come una specie di grigio incolore). Le piante necessitavano solo e soltanto della preziosa clorofilla per vivere, cioè di quel pigmento che permette loro di trasformare la luce solare in nutrimento. Per quanto riguarda la loro diffusione, le piante si affidavano essenzialmente a tecniche di riproduzione asessuata, oppure a qualche strategia più complessa di riproduzione incrociata, capace quindi di garantire un arricchimento genetico sostanziale di generazione in generazione, ove però i gameti erano affidati a forze naturali parecchio inaffidabili come il vento. Ovviamente queste tecniche riproduttive si osservano ancora oggi abbondantemente in natura, ma c’è una parte consistente del regno vegetale (le angiosperme) che, circa 130 milioni di anni fa, ha compiuto un salto evolutivo fondamentale, insieme con gli insetti impollinatori, e che ha dato vita così al mondo di colori e di profumi, di fiori e di frutti, che tanto amiamo.
Nel frattempo che le piante “capirono” che un insetto volante e ghiotto di zuccheri e proteine poteva trasportare il prezioso polline, ovvero patrimonio genetico, dagli stami di un fiore di un individuo all’ovario nascosto in un fiore di un altro individuo…. beh, nel frattempo un’ape che ancora non era proprio un’ape, scambiava delle forti mandibole da predatore per una lunga cannuccia fatta a mo’ di proboscide per succhiare meglio il nettare nascosto, e si riempiva il corpo di morbidi peli che si sarebbero involontariamente riempiti di polline nell’atto. Nel frattempo che le piante s’inventavano i fiori più sbalorditivi, colorati e profumati, per vincere la competizione con le loro compagne vegetali angiosperme, le api si munivano di una sacca capace di tenere il nettare raccolto per stivarlo poi in un nido, e di spazzole incredibilmente efficienti per confezionare il polline (fonte proteica) in delle comode palline facilmente trasportabili sulle borsette poste nelle zampe posteriori.
Ma, cosa ancora più stupefacente, le api quasi api si organizzavano in famiglie sempre più affiatate, talmente affiatate da diventare una società complessa di individui superspecializzati. Ora, arrivati a questo punto è quasi inevitabile incappare nell’analogia con noi esseri umani e la nostra società. Ma farlo è sicuramente un errore, forse dato anche dall’irresistibile antropocentrismo che spinge a misurare qualsiasi fenomeno naturale con la nostra specie come parametro (e alla fine affermare la superiorità dell’homo). Infatti, una famiglia di api è talmente una cosa sola da essere classificabile, biologicamente, come un “superorganismo”: è più esatto considerare una singola ape come una “cellula” del vero e proprio animale, l’alveare (una famiglia conta circa 50 mila api). In esso, l’organo riproduttore attivo e fecondo è posseduto solo dalla regina e, per le parti maschili, nei fuchi (le api maschio). Gli organi che consentono invece l’approvvigionamento di cibo e di acqua, o la costruzione del nido, sono beni esclusivi del popolo di api operaie.
Questo percorso evolutivo straordinario fa dell’ape mellifera una delle specie più efficienti e di successo nella storia di competizione (e cooperazione, ovviamente) tra genomi in atto fin dai tempi del brodo primordiale. C’è perfino chi considera l’ape un animale domestico, ma questo è davvero ben lungi dalla realtà. Come ha sottolineato l’entomologo Giorgio Celli, se l’uomo scomparisse dalla faccia della terra, alle api non importerebbe assolutamente nulla. O meglio, probabilmente non se ne accorgerebbero nemmeno. (E sempre Celli ci provoca immaginando un chihuahua che vaga disperato per le metropoli deserte, oppure una pianta di mais, oggi talmente selezionata per fini commerciali che non sarebbe più in grado di sopravvivere e riseminarsi senza l’ausilio dell’agricoltore).
No, l’ape non è un animale domestico. Grazie a dio homo sapiens non è mai riuscito a manipolare il suo corredo genetico a colpi di selezione, perché di fatto il modo in cui avviene l’atto sessuale tra le api rende particolarmente difficile l’intrusione dell’umano allevatore. (Ovviamente c’è chi al giorno d’oggi ci sta finalmente riuscendo, ma diciamo che per lo meno fino ad ora le api se la sono scampata). Già Plinio, nel suo Historia Naturalis, aveva scritto “neque mansueti neque feri” per descrivere l’ape, che non è domestica, ma comunque in un certo senso docile. Questo perché gli umani hanno costruito con le api, caso più unico che raro, un rapporto di simbiosi, più che di dominio e reciproca dipendenza. Cioè, gli umani sono senza dubbio dipendenti dalle api, ma lo sono per ragioni ecologiche, come lo sono dai lombrichi che rendono fertile il suolo e dal fitoplancton che apporta ossigeno nell’atmosfera.
E qui si arriva alla questione che sicuramente aspettavate di trovarvi leggendo questo articolo… la “morìa delle api”. Per capire l’entità del problema bisogna afferrare il fatto che le angiosperme che si sono evolute in quanto tali necessitano degli insetti impollinatori (di cui l’ape mellifera contribuisce per l’85%) per la fecondazione incrociata. Quindi per produrre frutti, e semi, ormai non possono fare a meno di questi animaletti. Homo sapiens, che si nutre di (e in definitiva dipende da) molti frutti delle piante in questione, se uccide le api si ritrova senza cibo – si consideri che due terzi delle piante coltivate sono angiosperme la cui impollinazione viene svolta da insetti. Ma perché le api muoiono?
Le campagne, luoghi che nel nostro immaginario rappresentano l’archetipo di “natura” e salubrità, sono diventati gli ambienti per molti versi più inquinati e antropizzati del territorio. L’agricoltura sembra non poter più fare a meno di spargere cisterne di insetticidi, erbicidi, fungicidi, fertilizzanti, rastrellando i campi con pesanti trattori tuttofare e tappezzandoli di teloni di plastica e serre. Nelle monocolture di meli in Valtellina, ad esempio, vengono fatti 30-35 trattamenti all’anno. Per non parlare delle vigne e, figuriamoci, nei campi di grano, mais, eccetera. Eppure i meli sono proprio tra le angiosperme che non producono frutti se non vengono impollinate dagli insetti pronubi.
Inoltre, a guardarle dall’alto, molte campagne assumono la triste forma di quadrati di un unico tappeto, per gran parte dell’anno spogli e tutti uguali, in cui gli ambienti selvatici, gli alberi tra i campi e le siepi sono sempre più risicati. Le api, che per sopravvivere hanno bisogno di tante fioriture diverse, che succedendosi per gran parte dell’anno diano loro nutrimento, si ritrovano in un ambiente privato della loro biodiversità di sempre, con molta meno vegetazione selvatica con cui nutrirsi e circondate di campi avvelenati e spogli. I cambiamenti climatici mettono a rischio quello che resta: le preziose fioriture sono sempre più spesso danneggiate da gelate primaverili e fenomeni metereologici anomali.
Gli apicoltori, che instaurano una forma di simbiosi con le api per ricavarne miele, propoli e altri prodotti, sono i primi ad accorgersi che le api nelle campagne subiscono pesanti stress. Molte vengono uccise dai veleni che gli agricoltori usano nei loro campi (veleni che comunque si spargono nell’aria, si accumulano nella terra, scolano nei corsi d’acqua), e tutte subiscono l’impoverimento e alterazione del loro habitat. L’agricoltura è diventata un disastro ecologico e il modo in cui homo sapiens produce il proprio cibo oggi è spaventoso. La morìa degli insetti impollinatori, con il loro ruolo essenziale e meraviglioso nell’ecosistema, è un fatto molto preoccupante. Se essi dovessero scomparire, aggiungendosi alla lunga lista di specie che si estinguono a causa delle attività antropiche, probabilmente avrebbe luogo il fatto più eclatante e degno di nota della breve esistenza di homo sapiens sulla Terra, innescando una catena di conseguenze a cascata che cambierebbero faccia al pianeta.
È davvero necessario mettere in atto forme di agricoltura alternative alla grande produzione, che non facciano uso di veleni, non distruggano il suolo né la biodiversità del territorio. Questo vuole senz’altro dire preservare porzioni di territorio in cui le api e gli altri insetti impollinatori (quanto son belli i bombi?) possano ancora trovare il loro habitat. Ma serve anche fare in modo che l’agricoltura intensiva smetta di fare danni incalcolabili, i cui effetti ricadono su tutti noi e su una miriade di altri esseri viventi.
Chi di noi non si dedica all’agricoltura ma ha a cuore il destino delle api potrà comunque cercare di sostenere un’agricoltura non industriale con le proprie scelte di consumo. E anche cimentarsi nel coltivare su giardini, poggioli e davanzali piante mellifere, come lavanda e timo. Anche in città, dove, paradossalmente, le api trovano spesso dimora.
Matilde Brunetti
Il ruolo-guida delle donne: ottenere un futuro paritario in un mondo di COVID-19
8 MARZO - Oggi, in occasione della Giornata...
La Scienza è anche roba da donne
In alcuni settori più di altri, la differenza di...
L’alfabeto dell’educazione: dall’abc al qwerty
Questa storia inizia con l’Abbecedario, il libro...